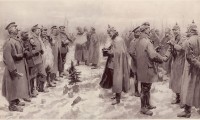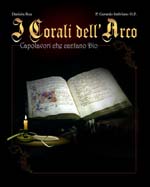 L’avventura degli otto libri corali del Santuario di Madonna dell’Arco inizia nell’agosto del 2009. Nel settembre dello stesso anno avviene il mio primo incontro con gli splendidi manoscritti: mai potrò dimenticare il fulmineo innamoramento per la bellezza degli antichi fogli e per il mistero che si cela nelle parole vergate sulla pergamena che immediatamente mi ha invaso l’anima.
L’avventura degli otto libri corali del Santuario di Madonna dell’Arco inizia nell’agosto del 2009. Nel settembre dello stesso anno avviene il mio primo incontro con gli splendidi manoscritti: mai potrò dimenticare il fulmineo innamoramento per la bellezza degli antichi fogli e per il mistero che si cela nelle parole vergate sulla pergamena che immediatamente mi ha invaso l’anima.
Lo studio, che si è protratto per quasi due anni, è stato il frutto di una riflessione maturata a lungo, e si è basato su ricerche concernenti la latinità e il mondo ecclesiastico e monastico che lo scrivente è venuto conducendo.
Molti sono stati i libri e abbondante il materiale filologico-linguistico e storico-archeologico consultato: il lavoro di un filologo ha sempre come punto di decollo quello di chi ci ha preceduto nel tempo — ci si riferisce ovviamente a ciò che ha una intrinseca validità, al di là delle soluzioni cui si perviene — e ad esso è quindi dialetticamente e storicamente legato.
Il volume I Corali dell’Arco vuole inserirsi sulla scia della cura e della valorizzazione del patrimonio librario e, al tempo stesso, proporsi come uno studio finalizzato ad assicurare frutti copiosi in termini di azione educativa, culturale, promozione di bellezza, ma soprattutto ha lo scopo restituire questo repertorio di natura religiosa e di significato culturale, affinché possa essere correttamente interpretato anche ai giorni nostri.
Operando una critica testuale si è cercato di seguire a ritroso i fili della tradizione, cercando di restituire i testi, quanto più fedelmente è possibile, nella loro primitiva forma. Si è mirato ad offrire un approccio problematico allo studio dei manoscritti, in forma rapida e necessariamente selettiva, ma abbastanza esauriente nei punti ritenuti fondamentali e, soprattutto, chiara e accessibile ad un arco non ristretto di lettori. Il libro, così concepito e strutturato, si rivolge a quanti intendono avvicinarsi a questa importante e sempre fascinosa scoperta, la quale mira a rimanere una delle più ricche di avvenire, per un periodo di tempo non breve, nel settore antichistico e che maggiormente ha ampliato e continua ad ampliare il nostro patrimonio di documentazione e di conoscenze dell’antichità classica.
I libri corali sono formati da pergamene finissime, vergati in un latino gotico che viene incorniciato dallo splendore di inimitabili miniature, in cui regna il principio di coordinare le note alla quantità delle sillabe e delle parole in una forma più consona al canto della lingua.
Essi appartengono alla famiglia religiosa dei domenicani e offrono un’immagine significativa della tradizione liturgico musicale dei secoli XVI e XVIII.
A parte le diverse peculiarità iconografiche e i diversi caratteri specifici delle decorazioni e delle miniature, i libri liturgici presenti nella pubblicazione rientrano — come accennavamo — nella categoria dei “corali”, cioè di quei libri di grande formato destinati all’uso comunitario durante le celebrazioni nel coro.
I canti liturgici, in generale, i nostri in particolare, sono brani semplici e melodie complesse, pezzi rigidamente sillabici e vocalizzi esuberanti nei quali centinaia di note si rincorrono in un vortice che purifica le parole lasciando decantare tutto ciò che è estraneo al linguaggio di Dio. Nel repertorio liturgico convivono brani totalmente diversi nella forma e nello stile.
Il compositore di brani liturgici non pretende di scrivere sempre nuove melodie per ogni testo eseguito dalla celebrazione. Ci sono alcune norme culturali e musicali da rispettare, quali, ad esempio, la funzione di un brano in un preciso momento di una particolare azione liturgica: ogni momento di un’azione liturgica ha una sua precisa connotazione e funzione che si riflette nel corrispondente canto che presenta delle peculiarità proprie.
Tutto costituisce un fitto sistema di coordinate da rispettare in modo rigoroso, ma nulla toglie all’atto creativo del cantore che improvvisa la sua elaborazione dell’idea musicale liturgica.
Essendo destinati ad una lettura collettiva dei membri del coro, i codici dovevano rispondere a criteri di chiara leggibilità, il che determinava il notevole ingrandimento del modulo della scrittura e della notazione: le dimensioni erano sempre più ampie, per rendere possibile la lettura simultanea di testo e musica ai folti gruppi di cantori, canonici, monaci o frati, radunati nel coro. Ciò, unitamente alla notevole entità del contenuto testuale e musicale, giustifica oltre che l’adozione del formato gigante, la suddivisione dei testi in più volumi. Il grande formato dei libri corali offriva, poi, al miniatore la possibilità di dispiegare tutta la sua abilità miniatoria e artistica, cimentandosi con figure e scene istoriate di notevoli proporzioni, quali non erano possibili nei codici normali.
I libri manoscritti sono, quindi, anche ricco scrigno di decorazioni e illustrazioni, simbolo di un’arte miniaturistica che, nonostante l’incremento della stampa e dell’incisione nell’illustrazione dei libri, continuava ad essere ampiamente praticata. Sono ricchissimi di iniziali istoriate e decorate, di eleganti fregi che si snodano con ritmi lenti lungo i margini delle carte con motivi ora filomorfi, ora geometrici, ora arabescati, sempre in una gamma di colori che vanno dal rosso al blu, all’arancio, al giallo, all’oro.
Per l’attribuzione di un manoscritto — o di un gruppo omogeneo che costituisce un unico libro religioso — ad una determinata famiglia religiosa, è significativa la presenza dei santi fondatori, protettori di qualche altro santo del medesimo ordine (oltre alla considerazione di ulteriori indizi o prove, quali emergono dall’esame musicale, testuale, codicologico e iconografico).
I grandi corali, più di ogni altro libro, divennero cosi la manifestazione anche simbolica del prestigio, della cultura artistica e del gusto di ricchi committenti, di istituzioni, di città. Trattandosi di manufatti impegnativi, sia dal punto di vista esecutivo sia da quello finanziario, chi ne curava I’allestimento tendeva a trasferire in essi caratteristiche consone alla sacralità dell’oggetto e al prestigio delle istituzioni committenti.
Largamente prodotti durante il XIV, il XV e il XVI secolo, ebbero iniziali miniate che avevano la funzione, sia tramite la scena o la figura rappresentata sia con i colori vivaci, di richiamare alla mente il testo e la musica. Tuttavia queste miniature, per la stessa grandezza dei volumi, e quindi delle iniziali, e per l’uso costante al quale i corali venivano sottoposti, non sempre ebbero grandi pregi d’arte o di finezza.
Per il resto, il libro corale, ornato di fastose e sfavillanti miniature, contribuiva al decoro e al fasto della liturgia, tanto quanto le pale d’altare, i paramenti, le suppellettili e gli apparati sacri. In genere, l’onere della loro esecuzione spettava alle fabbricerie delle chiese, ma non è raro il caso, in cui qualche fedele abbia concorso con i propri mezzi all’allestimento di questi sontuosi libri, in cambio di preghiere.
Nell’uso corrente, il vero canto corale o liturgico è il canto gregoriano. Infatti, molte delle melodie per i corali sono derivate dal gregoriano, a volte con piccole modifiche, o adattate alle nuove parole. Nel suddetto canto il ritmo è libero e la modalità diatonica, mentre in altri casi può colorire la linea melodica con il cromatismo moderato. I corali hanno una melodia piuttosto semplice e sono abbastanza facili da cantare, in quanto le parti sono per lo più condotte in forma omoritmica.
Conservati per secoli nei fondi originali (ad esempio il corale di Gerolamo nolano del 1614) o dispersi più o meno lontani (il caso degli otto “fratelli” dell’Arco finiti a New York), i corali dell’Arco testimoniano un uso prolungato nel tempo, con la preoccupazione di un costante aggiornamento di cui fanno fede le molteplici integrazioni come pure le rasure e le scritte sovrapposte: tanti indizi che rivelano la vitalità liturgica di una tradizione che sta modificandosi se non va, purtroppo, scomparendo del tutto.
I nostri corali sono sopravvissuti alla soppressione del monastero, anche se nel tempo alcuni di essi furono trafugati, altri, invece, privati di fogli miniati. Essi costituiscono oggi una testimonianza rara della miniatura che alla fine del Cinquecento era ormai al tramonto, ma della quale i manoscritti ora costituiscono un punto d arrivo.
I corali mostrano un aspetto inesplorato della nostra cultura figurativa. Sono, altresì infatti, corredati di rubriche, testi e intonazioni relative alle processioni e ai drammi liturgici che, giunti ormai alla fine del Medioevo, venivano ancora celebrati in cattedrale durante i riti delle feste solenni.
Per i nostri codici vale ciò che si propone a livello di codicologia liturgica per quanto concerne una serie di indagini campione. Esse vanno condotte su alcuni punti nevralgici, particolarmente significativi. Tra le diverse possibilità, va ricordato che ogni centro liturgico o ogni famiglia religiosa centralizzata possedeva determinate serie di testi standardizzati. I più conosciuti, e studiati, riguardano la serie degli Alleluia della messa per le domeniche dopo la Pentecoste e la serie dei responsoria delle domeniche d’Avvento.
I codici esaminati, offrono un’immagine significativa della tradizione liturgico-musicale propria dei secoli XVI e XVIII e il loro fortuito ritrovamento ha permesso di salvare questi volumi di inestimabile valore dalla sicura dispersione e soprattutto di salvarne il messaggio contenuto in essi: le parole e la musica.
Dal momento che molti testimoni manoscritti e a stampa sono andati dispersi, non è possibile descrivere e ricostruire nei minimi dettagli gli usi liturgici e musicali delle singole chiese locali. Il nostro caso è una delle poche eccezioni.
Questo libro intende essere una semplice introduzione per la divulgazione di alcuni dei segreti contenuti nei foli dei corali riscoperti, uno sforzo concreto, volto a far conoscere una ricerca di valore scientifico ma anche di indubbia attualità, di un patrimonio che appartiene alla nostra terra. I corali dovevano ripercorrere le tappe fondamentali dell’anno liturgico, ovviamente, non essendo in possesso del ciclo completo composto dai due autori, nel testo, verranno riportarti soltanto le celebrazioni di cui abbiamo testimonianza.
Questi libri sacri celebrano i misteri di Cristo, alla luce della Parola di Dio, per la salvezza del mondo, nella rinnovata ed esaltante possibilità che ogni anno la Chiesa dona nella sua liturgia. L’anno liturgico diventa un elemento imprescindibile del nostro percorso poiché in esso si esprime concretamente la vita liturgica della Chiesa ed esso plasma uno stile da assimilare. L’anno liturgico, inteso come ambito nel quale si celebra la liturgica eucaristica e quella delle ore, i sacramenti ed i sacramentali, esprime bene ciò che significa la spiritualità ecclesiale della sposa di Cristo che vive con il suo signore i misteri della sua vita, morte e resurrezione.
Sono volumi paragonabili ad una ricchissima galleria che richiama alla nostra memoria e ci aiuta a contemplare le tappe del mistero di Cristo grazie alle pagine aperte sulle singole feste, pagine che presentano insieme melodie e miniature. E come se riuscissimo a rivivere in concentrazione di esperienza spirituale e di bellezza, il lento svolgersi dell’anno, nella diversità delle situazioni che vanno dalla gioia intima del Natale, all’angoscia della Passione, all’esplosione del gaudio pasquale.
Per quanto tardivi rispetto ad altre fonti e benché il loro contenuto corrisponda in generale a quello diffuso nella Chiesa cristiana d’occidente a partire dai secoli X-XI, i nostri manoscritti presentano un interesse particolare perché custodiscono un repertorio completo e organizzato secondo il ciclo dell’anno, tutto in notazione musicale, ricco di elementi che testimoniano una tradizione locale. infatti, per quanto riguarda la tipologia codicologica, si tratta di graduali, kyriali e antifonari, ai quali occorre aggiungere ancora salteri, innari e codici con messe e uffici particolari.
Ciò che il volume “I Corali dell’Arco” vuole comunicare può essere espresso solo con l’intenzione che ne ha dettato l’adempimento: dare una consapevolezza sempre più articolata e precisa di alcuni momenti della storia degli studi che amiamo e coltiviamo, anche per dare una maggiore legittimità alla scelta e all’approfondimento dei temi di lavoro. Quindi, l’obiettivo è stato unire la teologia, l’esegesi alla filologia e alla paleografia. Filologia e paleografia sono discipline strettamente connesse tra loro e con lo studio delle letterature nazionali: per secoli i nostri antenati lessero e scrissero più frequentemente in latino che in volgare, e anche quando usarono le lingue nazionali come strumento letterario, ricorsero alle lingue classiche come fonti di cultura. La cultura latina aveva particolarmente informato di sé la cultura che nell’ideale della raison aveva riconosciuto il presupposto di ogni creazione letteraria. Altresì, gli studi di filologia classica nei tempi più recenti hanno ricevuto un notevole impulso in ogni parte del mondo. Si può forse dire che dopo il tragico esito del secondo conflitto mondiale, i filologi classici hanno acquisito una più marcata coscienza storicistica e storiografica.
Non vi è dubbio perciò che conoscere la storia dei nostri studi è un contributo alla nostra stessa formazione di uomini, di studiosi, di educatori.
Il volume sui corali del Santuario di Madonna dell’Arco vuole proporre una critica delle fonti, seguire l’evoluzione della lingua e portare alla scoperta di amanuensi, personaggi, monaci ignoti. Uno studio che, pertanto, ha voluto ricostruire e integrare sparsi frammenti della nostra cultura e civiltà, a costellare sempre più di oasi un immenso campo su cui discese il silenzio dei secoli. La domanda che vogliamo porci è “come”, ovvero capire le tipologie grafiche, la loro formazione, le loro caratteristiche formali, le loro tipizzazioni ed evoluzioni nel tempo.
Riteniamo che i nostri manoscritti siano tutti autografi, ne riscontriamo altresì uno acefalo e mutilo (datato 1603) di alcuni fogli interni.
Nei nostri foli notiamo alcuni casi di carta palinsesto: i codici originali sono stati raschiati per fare posto ad opere che in quel momento erano più richieste. Era questa una pratica variamente usata sia per questioni economiche sia perché magari il testo originario non era più utile e funzionale.
Leggendo i vari testi si riscontrano alcuni errori: la causa principale di essi, genericamente, viene indicata come l’incapacità dell’amanuense ad eseguire una copia precisa del resto, pertanto la maggior parte degli errori è da ritenere involontaria. Sembra a prima vista strano che l’attenzione degli scribi debba essere venuta meno tanto spesso, eppure chiunque può subito verificare, per esperienza, quanto sia difficile trascrivere in modo del tutto esatto un testo. Anzi, se si tiene nel debito conto il lungo arco di tempo durante il quale copiare a mano era l’unico mezzo di trasmissione, può parere straordinario che i testi antichi non siano stati ridotti più spesso ad uno stato inintelligibile. Molte trappole diverse si parano sulla via dello scriba se si permette di distrarsi un attimo.
Altro obiettivo del volume interessato ai corali del Santuario è di mostrare come l’esistenza della letteratura è dipesa tanto da fattori concreti, quali la forma dei libri e il materiale scrittorio, quanto da movimenti culturali e bellici, e anche di mostrare come il graduale evolversi dei metodi filologici ha aiutato gli studi letterari a sopravvivere e ne ha elevato la qualità.
Infine, c’è in chi scrive, una finalità latente, sempre celata tra i fogli dei corali: permettere a questi imponenti volumi di lasciar trapelare qualche accenno della storia dei Frati Predicatori di san Domenico, rievocando l’importanza e il valore della tradizione mariana nel santuario di cui essi sono custodi e colonna portante dal 1594, facendo qualche nota sulla loro profonda spiritualità che tocca l’origine e l’essenza più intima della Chiesa stessa, spiritualità basata sulla predicazione del Vangelo, come ideale autentico della propria vita, studiando, esplorando, scoprendo le vie migliori, più efficaci e nuove per diffondere il suo messaggio, preparando la strada per la nascita o l’approfondimento della fede in chi ascolta tale messaggio. Il domenicano è intrinsecamente e profondamente legato alla parola di Dio ed è per questo motivo che egli è in stretto contatto con la sacra scrittura, della quale egli studia, prega, vive e diffonde la buona novella.
I domenicani hanno portato a Napoli, e nella Chiesa in generale, un’ondata di freschezza e giovinezza.
I frati predicatori salirono ben presto in altissima fama di santità e di sapere e per vivaci opere di carità cristiana. Le prediche e le missioni di questi frati, molte delle quali sono per noi rimaste sconosciute, hanno fatto breccia nel cuore degli uomini e delle donne di tutti i tempi. Li hanno aiutati a crescere e maturare, o magari solo a
superare momenti difficili, ma sono destinati a rimanere nell’ambito della crescita spirituale dell’umanità, anche se non sempre ci sono — ripetiamo — grandi testimonianze scritte a ricordarcele.
Un ordine che ha profondamente sofferto durante gli anni delle soppressioni napoleonica e post-unitaria — ma non solo: religiosi che vennero privati di ogni cosa, comunità, casa lavoro, sicurezza e beni, fiducia nella vita e nelle persone, ma soprattutto uomini privati della loro dignità, violentata e umiliata. Le leggi della prima e della seconda soppressione degli ordini religiosi furono così deleterie, faziose e oppressive da non lasciare la possibilità di ripresa. Certo, nell’immediato post soppressione, non si potè subito pensare a far risorgere le biblioteche. Vi erano problemi più vitali che volevano la precedenza per sopravvivere.
Col tempo, però, alcuni frati volenterosi e coraggiosi, con dovuti permessi, da diversi conventi dell’ordine, raccolsero i libri che erano sfuggiti alla soppressione e li sistemarono nel convento di Madonna dell’arco — è questo il caso del corale datato 1614 già in possesso del santuario prima dell’arrivo da Londra degli otto “fratelli” — incrementando successivamente la raccolta con l’acquisto di libri nuovi. Ma è anche questo il caso, recentissimo, dei nostri otto corali.
Un’ultima nota va al ricordo di alcuni insigni nomi che rappresentano un laicato che si nasconde dietro l’ordine domenicano: Pier Giorgio Frassati, Giorgio La Pira, Aldo Moro, per accennare soltanto a tre campioni del laicato domenicano degli ultimi tempi.
Nel volume è stato possibile soltanto dare qualche cenno panoramico, piuttosto che operare una relazione dettagliata degli avvenimenti sullo sviluppo dell’ordine e in particolare sui Santuario di Madonna dell’Arco, perché il compito primario è stato incentrato sull’analisi dei manoscritti.
NOTE
1) Il Canto ebbe un ruolo importante nelle comunità evangeliche. Fin dagli inizi della riforma gli inni costituirono una parte integrante del culto. L’antichità cristiana, seguendo i consigli dell’apostolo Paolo , fece del canto un modo normale d’espressione della preghiera liturgica (Col 3,16).
2) Riteniamo che i corali dovesse essere di numero superiore. Otto sono quelli ritrovati a New York, uno (composto da Gerolamo nolano è datato 1614) era già in possesso del Santuario di Madonna dell’Arco. Inoltre, si ipotizza che altri, quelli contenenti altri momenti dell’anno liturgico o facenti riferimento ad altre figure di santi domenicani, siano ancora dispersi. La nostra ipotesi si avvalora anche dalla constatazione di altre collane di libri corali che contano anche 16 o 18 volumi, i quali ricompongono l’intero ciclo librario in sussidio alla liturgia corale dell’anno e ricoprono un arco temporale di composizione che va dal Duecento fino all’Ottocento inoltrato
Rea D. - Imbriano G., I Corali dell'Arco. Capolavori che cantano Dio, 2011