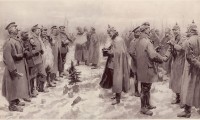Il rispetto delle idee altrui innanzitutto, e poi il rigore critico, il dubbio metodico, la moderazione, il non prevaricare e la tolleranza, sono le virtù del pensiero laico, così come ha scritto Norberto Bobbio. Laico è colui che ritiene di poter e dovere garantire incondizionatamente la propria e l'altrui libertà di scelta e di azione, rispetto a chi, invece, ritiene di dover conciliare o sottomettere la propria e l'altrui libertà all'autorità di un'ideologia o di un credo religioso. Storicamente il pensiero laico ha radici profonde e parallele rispetto a quelle del potere politico e religioso che da sempre hanno imposto ideologie e credi in contrapposizione all’universale assioma del laico: “l’individuo è sovrano”. Massima espressione della libertà, dunque, che se per il passato ha trovato ferrei oppositori nella politica e nella religione, oggi, di pari passo con le innovazioni scientifiche e l’affermarsi di modelli sociali evoluti, sta facendo sentire sempre più forte l’esigenza di una radicale innovazione sociale.
Nella storia della laicità, Napoli occupa un posto straordinario, di rilievo non solo italiano, ma europeo, basti pensare ai nomi di Federico II, di Lorenzo Valla, di Giordano Bruno, soprattutto di Pietro Giannone, degli Illuministi, dei Repubblicani del 1799, al periodo di Giuseppe Napoleone e Gioacchino Murat, ai protagonisti napoletani del Risorgimento, quelli del periodo dell’Italia liberale (1860-1924), e dell’antifascismo.
La religione, l’osservanza del dogma, fin dalla notte dei tempi, ha avuto un ruolo predominante sulla libertà dell’individuo e nelle strutture istituzionali. Nel medioevo il potere politico era fortemente intriso di carica sacrale, quasi tutte le monarchie ricevevano il diritto a governare dal papa stesso. Durante la lotta per le investiture si pose il problema dei rapporti gerarchici tra papato e sacro romano impero, una questione che si ripropose costantemente ogni qual volta salivano sul soglio imperiale personaggi di spicco, quali Federico Barbarossa o Federico II.
E proprio a Federico II, possono essere assegnati i primi vagiti di una vaga sensibilità laica napoletana, una straordinaria figura storica del Duecento che, nella sua tolleranza religiosa e curiosità culturale verso mondi non cattolici, come quelli musulmano e bizantino, nello scontro con la dura potenza papale (che arrivò anche a scomunicarlo nel 1227), nella promozione della prima scuola poetica della letteratura italiana (evento memorabile, giacchè la letteratura, con l’arte e la musica, è stata la sola via percorribile della libera creatività italiana, bloccata su altri orizzonti dalla debordante, dogmatica, violenta ‘potenza cattolica e papale’, annidata nel cuore della penisola), nella fondazione dell’Università di Napoli nel 1224 (non a caso a lui intestata e ancora oggi una delle poche roccaforti della laicità napoletana) per la preparazione soprattutto di personale burocratico, esperto di diritto romano, per far vivere uno stato più moderno, non pienamente confessionale e non impalcato solo su personale ecclesiastico. I nomi dei suoi collaboratori ‘laici’ come Pier delle Vigne di Capua, Taddeo da Sessa stanno ad indicare una sfera che non sarà mai più assente nella storia napoletana, quella di una tradizione, di un orgoglio giuridici e giurisdizionali, che cercheranno sempre di fronteggiare, pur nei duri limiti storici, la prepotenza e l’arroganza debordanti del mondo ecclesiastico.
Napoli si colloca nella storia europea con uno status singolare, che dà l’idea della difficoltà estrema della lotta per la laicità, per la distinzione tra chiesa e stato, in questa cara, tragica città: il papato romano, a partire dall’età normanna (XI secolo) ha preteso e imposto, dall’alto della sua potenza europea, che il neonato Regno di Napoli (prima area frantumata tra bizantini e longobardi) e di Sicilia (prima occupata dagli arabi e quindi musulmana) avesse una assoluta impronta cattolica, quindi si costituisse non solo come rigido ‘stato confessionale’, ma anche come ‘stato vassallo di Roma’, quasi sua proprietà feudale, segnalata dal diretto dominio papale di due territori nel cuore dello stato napoletano come Pontecorvo e Benevento, aree formalmente papali fino al 1860.
Segno esteriore di questo rapporto di vassallaggio era un tributo annuale che fu iniziato a pagare dal 1059. Esso fu più formalmente istituzionalizzato nel 1266 con Carlo I d’Angiò, con l’omaggio feudale, prima triennale, poi dal 1472 annuale, di una cavalla bianca che portava sulla groppa il tributo e che veniva consegnato al papa durante la festa di S.Pietro e Paolo il 29 giugno.
Il tributo fu soppresso nella prima età di Ferdinando IV, nel 1788, su impulso degli ambienti di governo riformatrici, su influsso dell’Illuminismo napoletano, che facevano capo al ministro Bernardo Tanucci (che si espresse anche con l’abolizione della Compagnia di Gesù, come avevano fatto prima le maggiori monarchie europee, giacchè quell’ordine era diventato troppo potente e pervasivo politicamente). Si tratta dell’unico contributo ‘laico’ che deve essere assegnato, per onestà storica’, al mondo borbonico, contributo che venne amplificato durante i sei mesi della Repubblica Napoletana del 1799 e soprattutto durante il perido francese (1805 -1815) quando Gioacchino Murat, operando un taglio netto tra gli affari di Stato e quelli della Chiesa, tra i vari provvedimenti, istituì lo Stato Civile, dando così al matriomonio il valore di atto sancito dallo Stato e non esclusivamente dalla Chiesa, così come era stato per secoli e non solo. Anche l'istituzione del Catasto andò ad innovare giuridicamente il censimento dei cittadini, fino a quel momento annotato, tra l'altro anche in modo molto approssimativo, dai sacerdoti, nei Libri dello Stato delle Anime del quartiere a cui faceva capo una parrocchia. La differenziazione degli affari dello Stato e quelli della Chiesa dunque, ma in special modo il senso della Libertà dell'indivduo, sovrano di se stesso e del suo Stato Laico, hanno rappresentato i pilastri della Costituzione Italiana del 1947, sorprendentemente attuale.